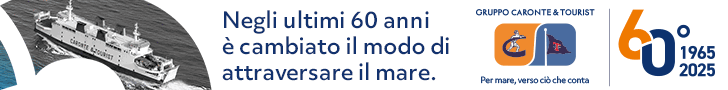Lo squillo. Breve storia malinconica di una rivoluzione a costo zero
Lo squillo. Breve storia malinconica di una rivoluzione a costo zero
di Giuseppe Miccoli
Una volta bastava uno squillo. Uno solo. E si capiva tutto.
Era il tempo della comunicazione analogico-digitale, dei Nokia 3310 con cover intercambiabili, delle suonerie polifoniche scaricate illegalmente da internet a 56k. Era il tempo in cui si parlava senza parlare, si amava senza emoji, e si comunicava… risparmiando.
Lo squillo era una specie di poesia telefonica. Un gesto minimo, invisibile, eppure carico di senso. In un secondo di vibrazione si poteva concentrare l’universo: “chiamami tu”, “sono arrivato”, “ti penso”, “non posso parlare adesso ma ci sono”, “ciao”, “ti amo”, “mi manchi”, “hai visto che ore sono?”. Il tutto senza spendere un centesimo, che era poi il vero miracolo semantico di questa rivoluzione sentimentale.
All’inizio fu la necessità, si sa. Fine anni ’90, inizio 2000: la diffusione dei primi cellulari ricaricabili nelle mani dei ragazzini portò con sé un problema strutturale di economia domestica. I genitori ricaricavano con parsimonia (una volta al mese, se andava bene), e chiamare o inviare un SMS era una scelta da ponderare più di una manovra finanziaria. Da lì, l’intuizione geniale: chiamare e riattaccare. Lo squillo era nato.
Un’arte povera, come le installazioni di Pistoletto. Ma con la stessa potenza simbolica.
E si sviluppò presto una grammatica precisa: uno squillo per dire “sto arrivando”, due per “scendi tu”, uno la sera per “buonanotte amore”. Un protocollo affettivo che si trasmetteva per osmosi nei corridoi delle scuole, sulle panchine del campetto, nei motorini in doppia fila. Uno squillo al giorno toglieva il dubbio di torno.
La bellezza dello squillo era nella sua leggerezza. Un gesto che non invadeva, non pretendeva risposta, non lasciava tracce ingombranti. Era il contrario del messaggio vocale di 2 minuti e 47 secondi che oggi ci arriva mentre siamo in coda alle poste. Era silenzio condiviso, presenza muta, connessione senza obbligo.
C’erano anche le regole non scritte: non si squillava a chi non capiva il codice. Non si squillava troppo, per non sembrare disperati. Non si squillava di notte, tranne che nei drammi d’amore adolescenziali (in quel caso era concesso uno squillo alle 2:47, seguito da settimane di silenzio e struggimento).
Lo squillo era anche un modo per dire “non posso parlare, ma volevo dirtelo lo stesso”. Un atto di resistenza romantica nell’era pre-Wi-Fi.
Poi, inevitabilmente, arrivarono le offerte. Le promozioni con SMS illimitati. Le Summer Card di Omnitel. Il 2×1 di Tim. Le tariffe senza scatto alla risposta. Il credito telefonico divenne meno prezioso. Lo squillo, un po’ alla volta, iniziò a scolorire. E con l’arrivo degli smartphone e delle app di messaggistica, si sciolse come neve al sole.
WhatsApp fece la sua comparsa e disse: “perché uno squillo, quando puoi mandare la tua posizione in tempo reale con la batteria all’8%?”
Telegram rilanciò con gli sticker animati.
Instagram introdusse i messaggi vocali a forma di goccia azzurra.
E lo squillo, quel piccolo miracolo economico-sentimentale, fu archiviato come fossile neolitico della comunicazione.
Oggi uno squillo ci mette ansia. È spam, è truffa. È un numero sconosciuto che vuole venderci pannelli solari. Lo squillo ha perso la sua innocenza. È diventato colpevole fino a prova contraria. E ai giovani d’oggi, se chiedi “ti faccio uno squillo?”, ti rispondono con una faccina perplessa, oppure con un meme.
Non è colpa loro. È che viviamo in un’epoca di sovraccarico comunicativo. Tutto deve essere notificato, letto, risposto, spuntato, archiviato. Non c’è più spazio per l’assenza comunicante. Non c’è più poesia nella mancanza.
Eppure, lo squillo resta nella memoria sentimentale di una generazione. Non lo celebriamo nei musei, ma ci torna in mente ogni tanto, come il profumo di una cabina telefonica in riva al mare, o il rumore del T9 che cercava disperatamente di scrivere “tvb” e invece proponeva “tavolo”.
Lo squillo era un segnale di riconoscimento. Un saluto sussurrato. Una tenerezza dissimulata. Era, forse, la forma più discreta e rivoluzionaria di affetto a distanza che abbiamo mai avuto.
Chissà se un giorno tornerà. Magari come gesto vintage, come i vinili o le polaroid. Magari in una scena di un film malinconico in cui lei fa uno squillo, lui non risponde, ma sorride.
E in quel gesto, tutto è detto. Come un tempo. Quando bastava un solo squillo per sentirsi vicini.