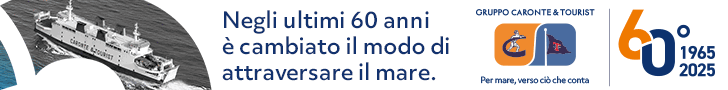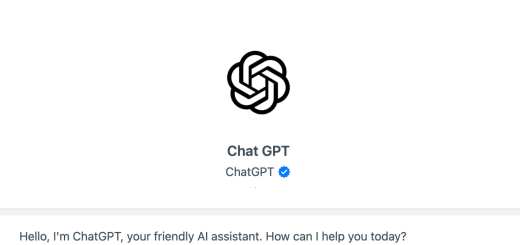Capelli lunghi, insulti e solitudine: l’Italia che non protegge i suoi figli

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita l’11 settembre. Due ore prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Si chiamava Paolo, amava la musica, la pesca e la cucina. Non erano hobby da alienato o da escluso, ma passioni vitali, radicate nella terra e nella cultura popolare, nelle mani che cucinano e negli occhi che guardano il mare. Eppure per la sua comunità scolastica, o almeno per una parte rumorosa di essa, bastavano i capelli lunghi a renderlo bersaglio. Un pretesto ridicolo trasformato in violenza quotidiana.
Ci chiediamo: perché la scuola ha abbandonato? Cosa significa che nessuno tra docenti e dirigenti ha colto il dolore di un ragazzo costretto a cambiare capigliatura per smettere di essere insultato come “Paoletta”, come “femminuccia”? La legge 70/2024 obbliga gli istituti a intervenire in caso di bullismo, a convocare i genitori, ad attivare percorsi educativi. Dov’era la legge, quando serviva? E soprattutto, dov’era la comunità educante?
Il fratello di Paolo ha scritto alla premier Meloni e al ministro Valditara: chiede che la morte di suo fratello non venga dimenticata. Ma la verità è che in Italia il bullismo resta un tema sottovalutato, spesso ridotto a “ragazzate” o a conflitti tra pari. La scuola, che dovrebbe essere luogo di crescita e di emancipazione, troppo spesso diventa il teatro della ripetizione delle disuguaglianze, dei pregiudizi, delle crudeltà che la società adulta non vuole guardare.
E allora dobbiamo chiederci: che cosa hanno in testa i giovani di oggi? La risposta non può limitarsi a un moralismo facile, alla condanna di una generazione “sbagliata”. I ragazzi di oggi crescono immersi in un ambiente digitale che amplifica le voci, soprattutto quelle dell’odio. I social media, nati come spazi di relazione, sono spesso diventati luoghi di accerchiamento e gogna, dove la derisione non si ferma al cancello della scuola ma continua nella chat di classe, nei gruppi WhatsApp, nei profili Instagram.
Gli investigatori hanno sequestrato i telefoni dei compagni: lì, tra meme e insulti, c’è il filo diretto con la morte di Paolo. È vero, i social possono fare molto: campagne educative, algoritmi di moderazione, strumenti di supporto psicologico immediato. Ma allo stesso tempo hanno già fatto molto, in senso opposto: hanno insegnato a una generazione che la visibilità conta più della sostanza, che il diverso va isolato, che il dolore altrui è contenuto da consumare in fretta.
Il problema, allora, non sono i giovani in sé, ma la società che li forma, la scuola che non interviene, la politica che si limita alle ispezioni quando ormai è troppo tardi. Paolo non era un “debole”: aveva passioni autentiche, concrete, sane. Forse avrebbe avuto bisogno di più strada e meno chat. Di un gruppo di amici con cui pescare al fiume o suonare la chitarra, piuttosto che di compagni pronti a umiliarlo in un gruppo WhatsApp.
Ma se i ragazzi non stanno più in strada, se non sperimentano il corpo, il gioco, il conflitto reale e regolato, allora tutto si sposta sul piano digitale, dove l’aggressione è senza volto e senza limiti. In questo senso, la scuola avrebbe dovuto fare da argine. Non con le circolari o i protocolli scritti, ma con la vigilanza quotidiana, con la capacità di leggere i silenzi, con un’educazione che non sia solo trasmissione di nozioni ma accompagnamento umano.
Perché un quattordicenne si suicida? Forse per la disperazione di sentirsi solo, di non intravedere vie d’uscita. La solitudine, nell’adolescenza, è un muro di cemento. E il bullismo, soprattutto se reiterato e amplificato dai social, diventa un carcere senza chiavi.
Paolo non doveva morire. Non doveva essere lasciato solo. La sua storia ci dice che la scuola non è stata all’altezza, che gli adulti non hanno visto, che i social hanno funzionato come cassa di risonanza dell’odio. Non basta piangere oggi, serve cambiare radicalmente prospettiva.
Bisogna ricostruire una comunità educante che sia davvero tale: scuola, famiglie, istituzioni e social media devono assumersi insieme la responsabilità. Altrimenti continueremo a raccontare di ragazzi che, come Paolo, salutano i compagni chiedendo un posto in prima fila: non in classe, ma nel loro funerale.