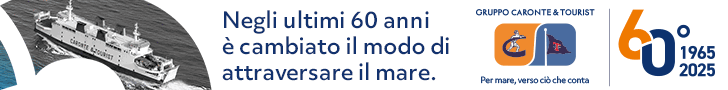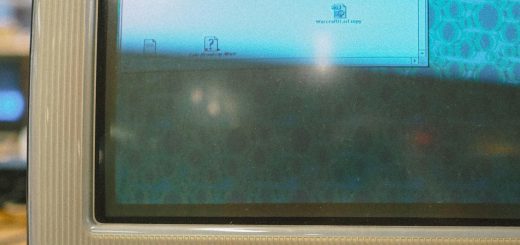Il costo della verità: X e TikTok nel mirino di Bruxelles

di Giuseppe Miccoli
Nel cuore dell’autunno digitale, mentre i feed si tingevano di rosso e grigio — colori della guerra e dell’incertezza — Bruxelles ha battuto un colpo. Questo mese, l’Unione Europea ha notificato a TikTok e a X (l’ex Twitter di Elon Musk) l’ennesimo ultimatum: basta disinformazione, o scatteranno sanzioni fino al 6% del fatturato globale. Il tutto sotto l’ombrello normativo del Digital Services Act, entrato pienamente in vigore proprio in quei giorni.
La miccia, prevedibile quanto devastante, è stata la nuova fiammata nel conflitto israelo-palestinese. I social, come sempre, sono diventati il primo campo di battaglia. Video decontestualizzati, foto riciclate, dichiarazioni mai pronunciate, bandiere scambiate, numeri gonfiati. In mezzo, una generazione che scrolla e condivide nel tempo di un battito d’occhio.
Secondo gli analisti, su X il 74% dei contenuti virali rivelatisi falsi proveniva da account con la spunta blu, quei profili a pagamento che Elon Musk ha trasformato in nuova moneta della credibilità apparente. TikTok, dal canto suo, ha moltiplicato visualizzazioni e monetizzazioni sull’onda emotiva della tragedia, lasciando che l’algoritmo premiasse il sensazionalismo.
Ma questa volta l’Europa ha deciso di non voltarsi. E non per censura, ma per responsabilità. Il DSA chiede alle piattaforme di intervenire rapidamente, segnalare, rimuovere, prevenire. Non basta più invocare la libertà d’espressione per legittimare la propaganda, né lavarsene le mani nel nome dell’algoritmo neutro.
La domanda è un’altra: può un continente regolare la verità nel tempo dei 15 secondi? E chi giudica, oggi, ciò che è dannoso?
Non è solo una questione di multe. È una questione di democrazia. Perché, come già insegnava Brecht, anche chi resta in silenzio di fronte alla menzogna — ne è complice.