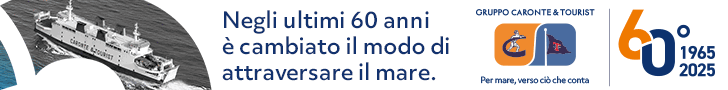Dalle 36 pose del rullino alle 27mila foto dello smartphone

di Giuseppe Miccoli
Ci sono persone che oggi si ritrovano con 27mila tra foto e video accumulati nello smartphone in soli cinque anni. Una cifra enorme, sproporzionata, che racconta meglio di ogni altra statistica quanto sia cambiato il nostro rapporto con la memoria visiva.
Eppure, non è sempre stato così. Fino ai primi anni 2000, il gesto di fotografare era raro, selezionato, persino costoso. Con le macchine fotografiche digitali compatte o reflex, le foto si scattavano solo in occasioni particolari: gite, viaggi, feste. Poi venivano scaricate sul computer e ordinate in cartelle ordinate da 40 o 50 immagini, non di più. Ogni evento aveva un suo album misurato, essenziale, comprensibile. Prima ancora, negli anni ’90, il limite era ancora più stringente: un rullino da 36 pose per immortalare un’intera gita scolastica di sette giorni. Non era pensabile fotografare tutto: bisognava scegliere con cura. E proprio questa necessità rendeva le foto più preziose.
Oggi quello che manca è il limite. Lo smartphone ha reso la fotografia onnipresente e gratuita: non c’è costo, non c’è attesa, non c’è più neanche la necessità di scaricare le immagini, perché restano nell’archivio digitale pronto a crescere all’infinito. Si fotografa di tutto: i piatti a tavola, i cartelli stradali, i tramonti ripetuti mille volte, i selfie identici. Il gesto non è più un atto di memoria, ma una reazione automatica, quasi un riflesso compulsivo.
Il paradosso è che più immagini produciamo, meno ricordiamo davvero. Le 36 foto di un viaggio degli anni ’90 avevano un valore narrativo: ognuna era un tassello di una storia, scelta e ponderata. Oggi, invece, centinaia di scatti di una singola giornata si confondono, indistinti, ripetitivi. L’abbondanza diventa rumore, e l’archivio sterminato ci rende incapaci di ritrovare un momento senza l’aiuto di un algoritmo che ce lo ripropone come “ricordo di tre anni fa”.
Ma non basta. Con lo smartphone è cambiato anche il destino delle foto: non restano più solo nel nostro archivio, ma finiscono subito sui social network, in uno spazio pubblico fatto di like, commenti e visualizzazioni. Non è più solo un gesto intimo, un modo per custodire ricordi: è un atto sociale, performativo, che chiede approvazione. Lo scatto diventa contenuto, e il ricordo diventa spettacolo. Una cena tra amici, un tramonto, persino un momento privato smettono di appartenere solo a chi li vive: appartengono a una comunità digitale che li giudica, li consuma e li dimentica alla stessa velocità con cui scorriamo il feed.
Non è nostalgia sterile: è una riflessione culturale. Il digitale ha cancellato la disciplina della scelta. Abbiamo affidato alla quantità il compito di proteggerci dalla paura di dimenticare, e ai social il compito di dare valore attraverso l’approvazione degli altri. Ma ricordare non significa accumulare né esibire: significa attribuire significato. Un album fotografico cartaceo, con poche immagini, è ancora oggi più potente di una galleria da migliaia di file mai rivisti o da un post che scompare nel giro di un giorno.
Forse la vera modernità non è smettere di usare lo smartphone o i social, ma imparare a riconquistare la consapevolezza del gesto. Chiedersi: questa immagine serve davvero? Racconta qualcosa che vale la pena ricordare? Oppure è solo l’ennesima ripetizione di un attimo indistinguibile?
Non torneremo ai rullini da 36 pose, né alle cartelle da 50 foto sul computer. Ma possiamo imparare da quella lezione: i limiti non erano un difetto, erano un filtro che dava senso. Oggi tocca a noi reinventare quei confini. Perché una foto non serve ad avere tutto, né a raccogliere like: serve a raccontare ciò che vale la pena non dimenticare.