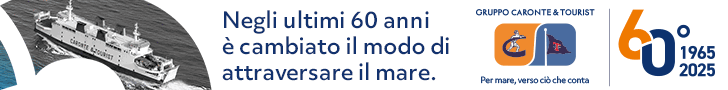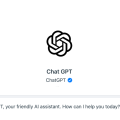Dallo Zingarelli a ChatGPT: la morte lenta dello studente analogico

Nel 2004 uno studente del liceo classico aveva bisogno di tre cose per fare i compiti: un libro, un dizionario e silenzio. Non esistevano notifiche, distrazioni digitali, feed infiniti da scorrere. La ricerca si faceva sui volumi di carta, le versioni si traducevano sfogliando il Castiglioni Mariotti, e le tesine si stampavano con Word e Office 2003. Il PC era fisso, spesso condiviso con genitori e fratelli. Internet c’era, ma si usava con parsimonia: un’ora di connessione ADSL era un piccolo lusso.
Studiare era un gesto solitario, lento, quasi fisico. Il sapere aveva un peso, un odore, una presenza. La scuola era un tempio, non una nuvola digitale. Ogni conoscenza aveva il suo contenitore, ogni materia il suo lessico. Si sbagliava di più, ma si imparava anche ad arrangiarsi. E il tempo passato sui libri era un tempo interamente dedicato all’apprendimento.
Oggi, nel 2025, tutto è cambiato. E non è detto che sia un bene.
Lo studente moderno ha un arsenale digitale a portata di mano: tablet, laptop, app per mappe concettuali, dizionari digitali, traduttori automatici, strumenti di sintesi testuale. Scrive con Notion, legge in PDF, ripassa con i podcast e si fa spiegare Platone da una voce su YouTube. Ogni dubbio può essere sciolto in 5 secondi, ma spesso senza sedimentarsi.
La scuola è entrata nel cloud, ma ha perso il contatto con la terra. La carta è sparita, la memoria si è alleggerita, l’attenzione si è frantumata. Le interrogazioni sono diventate test online, i compiti si consegnano con un clic, e le ricerche si fanno “promptando” un’intelligenza artificiale. Studiare non è più cercare, ma filtrare. Non è più approfondire, ma orientarsi in superficie.
E se da un lato è vero che l’accesso alla conoscenza non è mai stato così democratico, dall’altro la dipendenza dalla tecnologia sta svuotando lo studente della sua autonomia critica. Meno errori, sì, ma anche meno scoperta. Meno frustrazione, ma anche meno desiderio. In fondo, se tutto è a portata di mano, cosa vale davvero la pena imparare?
Lo studente del 2025 rischia di sapere tutto senza comprendere nulla. Un paradosso che mette in crisi non solo l’educazione, ma anche la nostra idea di intelligenza. Perché la vera sfida non è usare meglio la tecnologia, ma ricordarci che non potrà mai sostituire il pensiero.
Il sapere non ha bisogno solo di velocità, ma di profondità. Di tempo. Di fatica. Forse anche di un po’ di noia. Forse, per imparare davvero, dovremmo tornare a spegnere il Wi-Fi ogni tanto.