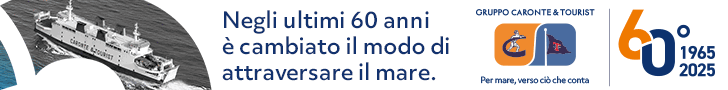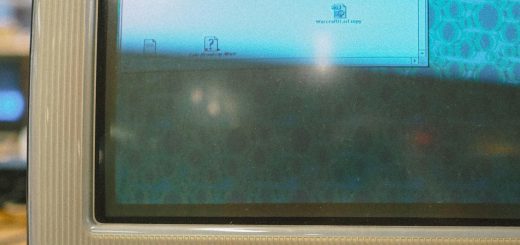Erasmus senza Wi-Fi

di Giuseppe Miccoli
C’era un tempo in cui partire per l’Erasmus significava sparire davvero per un po’. Niente storie Instagram, niente chat su WhatsApp, niente voli last minute prenotati in un click. Solo una valigia pesante, una cartina piegata nello zaino e l’indirizzo scritto su un foglietto, magari consegnato da un’amica che “conosceva uno che era stato lì l’anno prima”. Era l’inizio degli anni Duemila, quando la rete era lenta, i telefoni cellulari servivano a telefonare e mandare SMS, e “Google Maps” era una combinazione di intuizione, cartine turistiche e passanti gentili. L’Erasmus, allora, era un viaggio nel senso più profondo del termine: un esercizio di adattamento, lentezza e fiducia.
Appena arrivati in una nuova città, la prima tappa non era il Wi-Fi, ma l’ufficio turistico. Lì si riceveva una mappa cartacea enorme, piegata male, che si apriva con un colpo secco come un lenzuolo al vento. Non c’erano pin blu né frecce lampeggianti: solo linee, nomi di strade e chiese disegnate in prospettiva. Orientarsi significava fermarsi agli angoli, guardare i palazzi, cercare un campanile o una piazza riconoscibile. E se ci si perdeva — cosa frequente — non si tirava fuori un telefono, ma si chiedeva ai passanti, spesso in lingue approssimative, con gesti e sorrisi che diventavano parte integrante del viaggio.
Per chiamare casa si andava nelle cabine telefoniche a gettoni o con schede prepagate. Le chiamate erano brevi, spesso disturbate, e cominciavano sempre con un “Mi senti? Mi senti adesso?”. Chi aveva fortuna e qualche soldo in più poteva mandare SMS dall’estero, pagando tariffe esorbitanti. Le videochiamate erano una fantasia da romanzo di fantascienza. L’assenza di comunicazione immediata aveva un effetto curioso: si imparava a stare nel presente, a risolvere da soli piccoli problemi quotidiani, a non avere sempre una voce pronta a rassicurarti dall’altra parte dello schermo.
Nelle università europee di quegli anni, le aule computer erano luoghi affollati e silenziosi. File di studenti aspettavano il proprio turno per mandare un’email alla famiglia o al fidanzato rimasto in Italia. La casella di posta era un diario a puntate, e le risposte arrivavano dopo giorni, non secondi. Chi aveva un laptop era considerato un pioniere. Le connessioni erano lente, spesso cablate. Nessuno controllava compulsivamente le notifiche: semplicemente perché non ce n’erano.
Facebook nasce nel 2004, ma per anni è rimasto confinato nelle università americane. Instagram e WhatsApp non esistevano. La vita Erasmus non era documentata in tempo reale, e questo apriva spazi di libertà oggi quasi impensabili. Si usciva senza l’ansia di fotografare tutto, senza la pressione di costruire un’immagine digitale coerente. I ricordi erano nei diari, nelle lettere, nelle fotografie stampate con pellicole da 24 o 36 scatti. Ogni foto era pensata, non scattata in serie. Ogni racconto arrivava per posta o a voce, al ritorno.
L’assenza di tecnologia non era una mancanza, ma una condizione condivisa. Tutti erano “disconnessi”, e questo creava un senso di comunità reale. Gli incontri non si cercavano con app, ma accadevano nei corridoi, nelle piazze, nelle cucine degli studentati. Ci si dava appuntamento “davanti alla fontana alle sette”, e se qualcuno arrivava tardi, si aspettava. Non c’erano notifiche a ricordartelo. Quell’attesa, oggi quasi inconcepibile, era parte integrante dell’esperienza: insegnava pazienza, fiducia, imprevisto.
Chi ha fatto l’Erasmus tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila lo racconta con una nostalgia particolare. Non è solo nostalgia per la giovinezza, ma per un modo diverso di stare nel mondo. In un’epoca senza mappe digitali, l’Erasmus formava la capacità di perdersi e ritrovarsi, di costruire reti umane non mediate, di scrivere lettere e camminare senza GPS. È stata una palestra di autonomia e lentezza. Intere generazioni europee hanno costruito legami profondi senza essere connesse 24 ore su 24. Si sono innamorate senza Tinder, hanno trovato case bussando alle porte, hanno imparato le lingue ascoltando e sbagliando, non con app didattiche.
Non si tratta di idealizzare il passato. I viaggi erano più complicati, le solitudini più acute, le informazioni più difficili da trovare. Ma quella complessità era parte integrante del viaggio, e lasciava un segno duraturo. Oggi un Erasmus è accompagnato da Google Translate, gruppi WhatsApp, voli low cost e connessioni ovunque. È più sicuro, più efficiente, ma forse un po’ meno avventuroso. Ripensare a quei tempi significa interrogarsi sul senso profondo del partire: non solo spostarsi, ma trasformarsi. E ricordare che, a volte, perdersi è la via più autentica per conoscersi davvero.