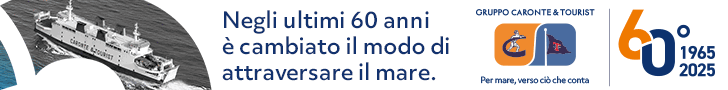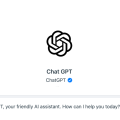Italia offline: il caso ChatGPT e la crisi della sovranità digitale
In un silenzio più assordante delle grida, un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali imponeva a ChatGPT – il più noto strumento di intelligenza artificiale conversazionale – lo stop immediato. Per la prima volta in Europa, un paese metteva al bando una delle tecnologie più emblematiche della nuova era digitale. Il motivo? Violazione della normativa sulla privacy. L’accusa: non essere in grado di garantire che i dati personali degli utenti fossero trattati secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Dietro quella decisione, apparentemente tecnica, si nascondeva una questione politica ben più profonda: chi controlla l’intelligenza artificiale?
Per un mese, l’Italia è rimasta isolata dal flusso globale che ormai permea scuole, aziende, giornalismo e sanità. ChatGPT – già allora sulla bocca di tutti – diventava non disponibile in territorio italiano, come fosse un sito pirata o un contenuto in violazione di copyright. Nessuna sentenza, nessun dibattito parlamentare. Solo un provvedimento d’urgenza.
Molti hanno accolto la scelta come un atto di coraggio regolatorio. Finalmente un’autorità nazionale si opponeva alla supremazia delle big tech. Finalmente si metteva un argine al far west della data economy. Ma il punto è: è bastato? È servito?
Ad aprile, dopo alcune modifiche tecniche da parte di OpenAI, l’accesso è stato ripristinato. Il sistema è tornato operativo, e tutto è sembrato tornare alla normalità. Ma quale normalità?
Il nodo rimane irrisolto: non esiste ancora una governance europea unitaria sull’intelligenza artificiale, e i tentativi del Parlamento europeo di introdurre l’AI Act viaggiano a rilento, tra pressioni industriali, paure securitarie e ambiguità lessicali.
In questo vuoto normativo, l’Italia ha fatto da battistrada. Ma senza un dibattito pubblico degno di questo nome. Nessun confronto democratico, nessuna valutazione etica sul modello linguistico e sulle sue implicazioni per il lavoro, l’informazione, la scuola.
Si è trattato di una questione giuridica, certo, ma anche simbolica: la tecnologia non è neutrale, e ogni blocco o sblocco riflette un’idea di società, di controllo, di libertà.
Nel frattempo, l’uso dell’intelligenza artificiale si è moltiplicato. Nelle redazioni giornalistiche, nei social media, nei sistemi giudiziari. Nessuno può dirsi immune. Ma nessuno, nemmeno gli esperti, può davvero prevedere le conseguenze a lungo termine di questi strumenti.
Serve una nuova alfabetizzazione democratica del digitale. E non può venire solo dai garanti, dalle authority o da tecnici chiusi in stanze algoritmiche. Deve essere un processo collettivo, critico, partecipato.
Perché oggi, in Italia, non è in discussione solo l’accesso a ChatGPT. È in discussione il nostro diritto a capire, a scegliere, a decidere se e come vogliamo convivere con le macchine che ci parlano.