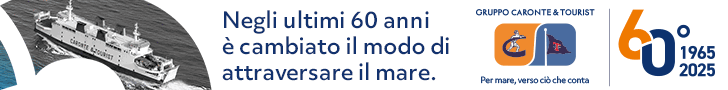La disillusione di Twitter e le ambizioni degli altri

di Giuseppe Miccoli
Le piattaforme digitali continuano a rincorrere futuro e profitto, oscillando tra promesse di innovazione e fragilità strutturali. È il caso di Twitter, che, dopo l’acquisizione di Elon Musk, sembra avviato verso una perdita di oltre 30 milioni di utenti entro il 2024. Un dato che, più che un numero, rappresenta un simbolo: la parabola di un social nato come voce globale e ridotto oggi a palcoscenico personale del suo proprietario, in una deriva che molti utenti interpretano come il fallimento del sogno di una “piazza pubblica digitale”.
Se Twitter implode, altrove si cerca di costruire. LinkedIn, spesso relegato a piattaforma grigia per professionisti, ha scelto proprio gennaio 2023 per annunciare un pacchetto di novità che la proiettano oltre la sua tradizionale funzione di vetrina dei curriculum. Le promesse riguardano una maggiore accessibilità per utenti con disabilità, l’apertura a opportunità di carriera esplorabili in modo più “casuale”, come se l’algoritmo volesse farsi complice di scoperte inaspettate, e la creazione di Product Pages: spazi dove non solo si presentano aziende, ma si guidano decisioni di acquisto, fondendo lavoro e consumo in un unico ambiente.
Un’altra novità, forse la più pragmatica e meno scenografica, è la possibilità di programmare i post direttamente su LinkedIn. Un gesto apparentemente minimo che, in realtà, rappresenta la normalizzazione di uno strumento che altri social già offrono, ma che qui assume un significato preciso: la piattaforma non vuole più essere un diario occasionale, bensì un hub di comunicazione strutturata, capace di competere sul terreno del content marketing e della narrazione aziendale.
Nel frattempo, Snap non resta a guardare. Se Facebook e Instagram continuano a inseguire i giovani e TikTok detta la grammatica della comunicazione istantanea, l’ex Snapchat ha scelto una via diversa: la realtà aumentata. A gennaio 2023 ha infatti lanciato, in collaborazione con Amazon, un’esperienza di virtual try-on per occhiali. L’utente può indossare digitalmente un paio di lenti, muoversi, osservarsi nello specchio del proprio smartphone e decidere l’acquisto con un clic. Non più soltanto messaggi e contenuti effimeri, ma un ponte diretto tra desiderio, immagine e consumo.
Dietro queste mosse si intravedono tre traiettorie diverse ma intrecciate. Twitter, col suo declino, mostra come un social possa implodere se il suo tessuto comunitario viene sacrificato all’egotismo proprietario. LinkedIn, al contrario, punta a espandersi trasformandosi da rete professionale a spazio di ibridazione tra lavoro, consumo e marketing. Snap, infine, scommette sul futuro della realtà aumentata come esperienza di acquisto immersiva, consapevole che il confine tra socialità e commercio è ormai inesistente.
La sensazione, in questo inizio 2023, è che le piattaforme non parlino più agli utenti come cittadini digitali, ma come consumatori permanenti. La socialità si misura in like, l’accessibilità in termini di mercato potenziale, l’innovazione come opportunità di monetizzazione. Persino la funzione più banale – la programmazione di un post – diventa un tassello in questa economia dell’attenzione senza tregua, dove il tempo non è più nostro, ma materia prima da estrarre.
Eppure, in filigrana, rimane una domanda che riguarda tutti: che cosa resta della promessa originaria dei social media? Erano nati per connettere, per ridurre le distanze, per aprire spazi di dialogo. Oggi, guardando le cronache di gennaio 2023, appare chiaro che ciò che si connette non sono più soltanto persone, ma interessi economici. Twitter si sgonfia, LinkedIn si reinventa, Snap sperimenta: e noi, spettatori e utenti, restiamo al centro di un laboratorio che raramente chiede il nostro consenso.