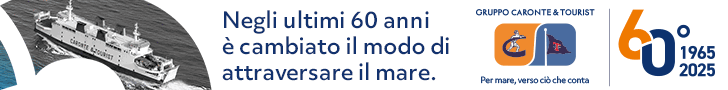La moltitudine connessa: 4,88 miliardi di identità attive sui social media. Ma a quale prezzo?

Siamo connessi, dunque siamo? La domanda può sembrare vecchia, ma i numeri aggiornati impongono una riflessione nuova. A luglio 2023, le identità attive sui social media hanno raggiunto quota 4,88 miliardi: il 60,6% della popolazione mondiale vive quotidianamente un’esistenza anche dentro un feed. La crescita rispetto all’anno precedente è stata del 3,7%, ovvero 173 milioni di nuovi ingressi in questa piazza globale sorvegliata e plasmata da logiche private.
Nel tempo della crisi climatica, delle guerre periferiche che si moltiplicano, delle economie frantumate e delle nuove povertà, il mondo digitale non conosce battute d’arresto. Anzi, si espande. E lo fa seguendo la mappa delle disuguaglianze. Perché dietro questi numeri apparentemente neutri si nasconde una geografia ineguale: più del 90% degli utenti si concentra tra Asia, Europa e Americhe, mentre molti paesi africani restano ai margini dell’ecosistema digitale. Il “villaggio globale” non è mai stato così diseguale.
Ma non è solo questione di accesso. È anche una questione di identità. Perché cosa significa avere un’identità attiva? Non si tratta soltanto di avere un account, ma di esistere dentro una grammatica, un linguaggio, un algoritmo che seleziona ciò che vediamo, ciò che desideriamo, ciò che crediamo di pensare. È la trasformazione della cittadinanza in “utente”, della soggettività in profilo di consumo.
Eppure, di fronte a tutto questo, la politica arranca. Si discute – troppo poco e male – di regolamentazioni, di leggi sulla privacy, ma intanto le piattaforme si moltiplicano e consolidano: Threads di Meta tenta di raccogliere i delusi di Twitter (ora “X”), TikTok continua la sua avanzata tra le nuove generazioni, e perfino LinkedIn si trasforma in un ibrido tra CV e diario motivazionale.
Ma chi governa tutto questo? Non certo gli Stati, né le agenzie pubbliche. Il potere è saldamente in mano a poche multinazionali tech che definiscono regole opache, spesso inaccessibili, e si muovono con agilità tra giurisdizioni e continenti. È il tecno-capitalismo, che ha sostituito la piazza con l’interfaccia, la comunità con il cluster.
Il paradosso è che più diventiamo “visibili”, più siamo controllati. Ogni like, ogni scroll, ogni pausa di attenzione è un dato che alimenta modelli predittivi, pubblicità mirata, persuasione cognitiva. Non siamo solo fruitori, siamo materia prima. Un gigantesco giacimento emotivo da monetizzare.
Nel frattempo, la comunicazione pubblica – quella delle istituzioni, delle scuole, dei media indipendenti – fatica a trovare linguaggi adeguati. Insegue, copia male, si frammenta. I social sono diventati lo spazio principale dove le persone si informano, si indignano, si organizzano. Ma è anche lo spazio dove regna il caos, la superficialità, l’hype. Dove la verità è un algoritmo e la menzogna ha lo stesso peso specifico.
E allora? Cosa fare, davvero? Serve una nuova alfabetizzazione digitale, ma non solo tecnica. Serve una pedagogia critica della rete. Serve una riflessione collettiva su cosa significa abitare il digitale senza esserne schiacciati. Perché il futuro non si gioca solo con la fibra ottica e le app, ma con le domande che sappiamo ancora porci.
Se 4,88 miliardi di identità sono attive, non significa che siano libere. Il nodo non è esserci, ma come esserci, e soprattutto, per chi.