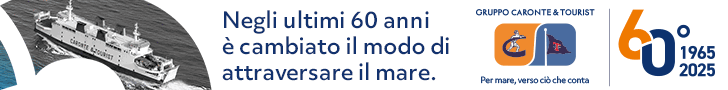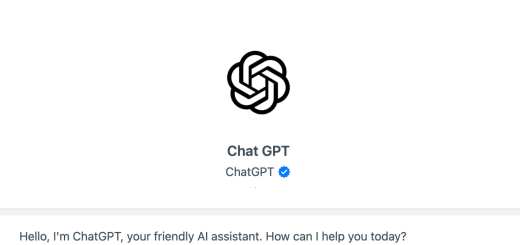Quando la rete si rompe: il Web Summit e il prezzo delle parole
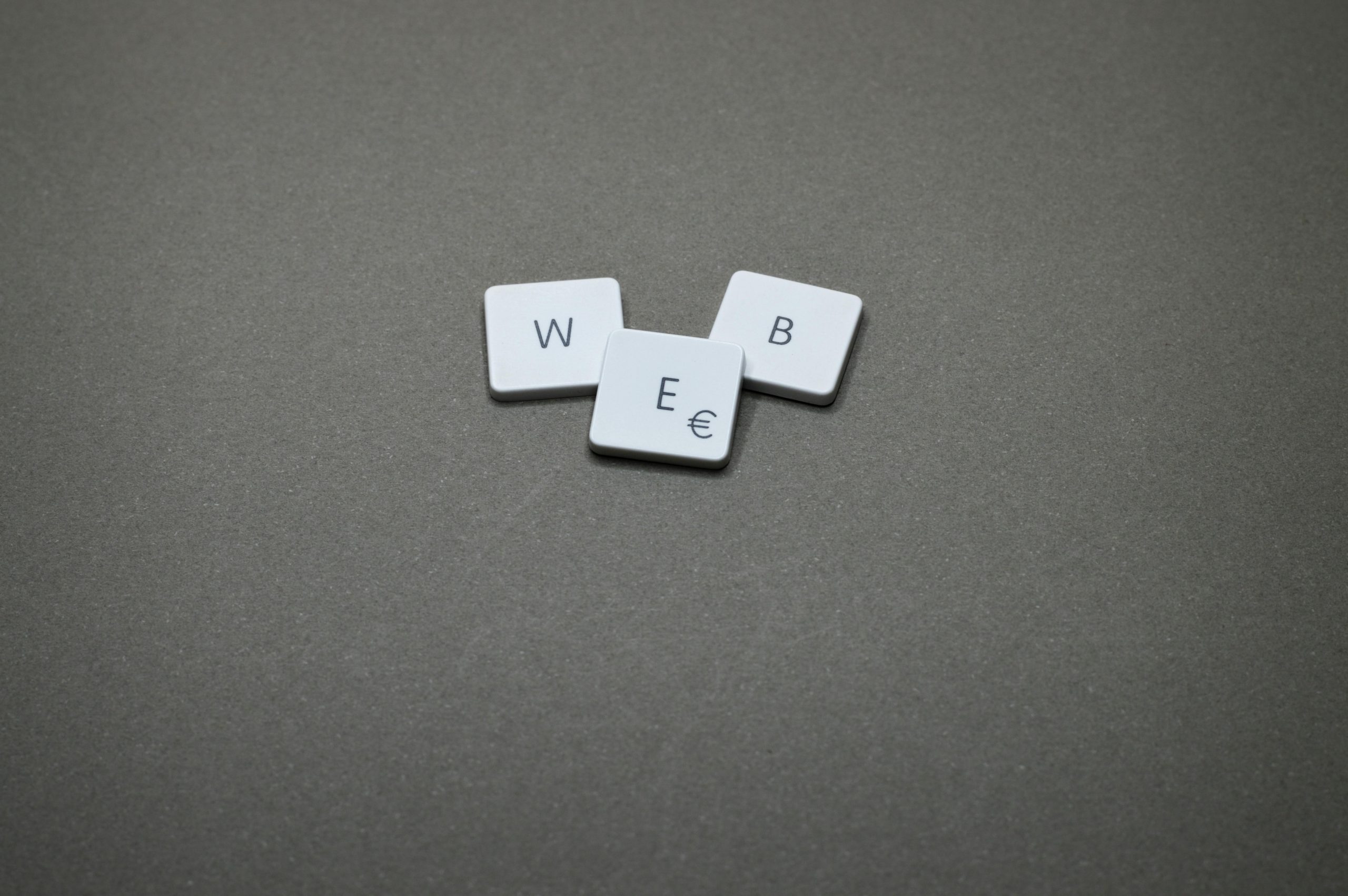
di Giuseppe Miccoli
Non è solo un evento tech. Il Web Summit è, da anni, il salotto buono della tecnologia europea. Un palcoscenico dove si incontrano startup, fondi, governi, giornalisti e intelligenze artificiali. Ma nell’ottobre del 2023, quel palcoscenico si è trasformato in campo minato. La scintilla: alcuni post del fondatore e CEO Paddy Cosgrave sulla guerra tra Israele e Hamas. La conseguenza: una valanga diplomatica, aziendale e simbolica.
Cosgrave ha scritto — via X, ovviamente — che “i crimini di guerra sono crimini di guerra, anche quando a commetterli è un alleato occidentale”. Una frase tanto generica quanto deflagrante. In un contesto già infiammato, le sue parole sono state percepite come una presa di posizione filopalestinese, o peggio, una relativizzazione della violenza di Hamas.
In pochi giorni, sponsor come Google, Meta, Amazon, Intel, Siemens e persino governi interi (tra cui quello israeliano) hanno cancellato la loro partecipazione. Le reazioni sono state durissime. E il Web Summit, da evento globale, si è ritrovato improvvisamente senza interlocutori, senza voci, senza consenso.
Il 21 ottobre, Cosgrave ha annunciato le sue dimissioni. “Le mie opinioni personali sono diventate una distrazione per l’evento”, ha scritto. Ma la domanda resta: può il fondatore di un evento tech essere punito per ciò che pensa? O, più precisamente: chi decide oggi quali opinioni possono esistere nel mondo della tecnologia?
A sostituirlo è arrivata Katherine Maher, già CEO di Wikimedia Foundation, una figura attenta all’equilibrio tra libertà digitale e responsabilità pubblica. Ma la crisi aperta dal caso Cosgrave non si chiude con un cambio di leadership. Il nodo è più profondo: la tecnologia non è più neutra, e nemmeno chi la rappresenta può più esserlo.
Il Web Summit 2023 ci ha ricordato che la geopolitica ha raggiunto i codici e i palchi dell’innovazione. Non ci sono più luoghi innocenti. Anche chi crea strumenti è responsabile del loro uso. Anche chi organizza eventi, se esprime un’opinione, può scatenare boicottaggi e tempeste.
Nel tempo in cui le Big Tech si comportano da potenze globali, il silenzio è diplomazia. E la parola, anche quella personale, anche quella postata di notte, può valere milioni. Può mettere in discussione un evento, una carriera, un intero ecosistema.
Cosgrave è uscito di scena. Ma la sua uscita ha aperto una porta su una questione che resterà aperta: esiste ancora uno spazio per il dissenso, nell’industria dell’innovazione? O tutto è subordinato al capitale, alla linea politica degli sponsor, alla fragile percezione pubblica?
Nel salotto buono della tecnologia, anche un tweet può diventare un’esplosione.