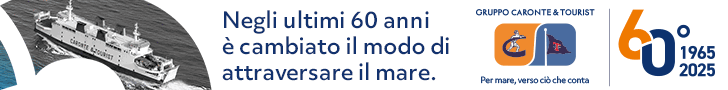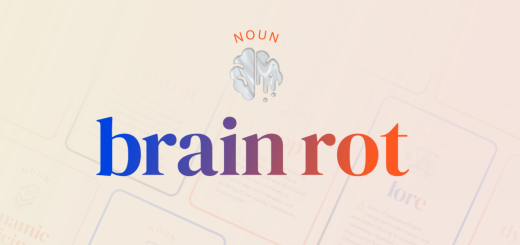La scienza si dà in pasto all’algoritmo

di Giuseppe Miccoli
Nel tempo in cui la verità si misura in “engagement”, anche la scienza è chiamata a ballare sulla pista luminosa dei social media. A dirlo non è uno strategist, ma la Commissione Europea. In un articolo pubblicato l’11 agosto 2023 sul portale ufficiale dell’Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA), Bruxelles invita apertamente i ricercatori finanziati da Horizon Europe a “potenziare la comunicazione scientifica attraverso Twitter e LinkedIn”. Non solo un consiglio, ma una direzione politica: la scienza deve diventare contenuto. Il laboratorio si trasforma in stories, il ricercatore in creator.
Non è una provocazione. L’articolo racconta come alcuni progetti europei abbiano aumentato la visibilità dei propri eventi raddoppiando le presenze grazie a thread, interviste video brevi e post taggati. “I social media funzionano”, dice uno dei coordinatori intervistati. Funzionano, sì. Ma per cosa?
Il cuore della questione è tutto qui: cosa significa comunicare la scienza nel tempo dell’algoritmo? È davvero un progresso rendere la ricerca accessibile attraverso clip di 30 secondi, grafiche animate e filtri colorati? O stiamo semplicemente addestrando anche la conoscenza a piegarsi alle regole della visibilità?
L’Europa non impone, ma suggerisce: “raccontate il vostro progetto con un linguaggio semplice”, “usate Twitter per creare comunità”, “LinkedIn per rafforzare la rete professionale”. Tutto legittimo. Ma il rischio è trasformare la comunicazione scientifica in un esercizio di marketing istituzionale, dove il valore è stabilito non dal contenuto, ma dalla sua performance numerica.
Eppure la necessità di comunicare la scienza è reale, urgente. In un mondo devastato da disinformazione e deliri negazionisti, non si può più chiudere la conoscenza dentro le accademie. Ma forse il problema non è se comunicare, ma come. Serve costruire nuovi linguaggi, non solo adottare quelli che vanno di moda. La scienza non può inseguire il like, deve creare lo spazio per una comprensione critica. Altrimenti, più che una nuova forma di democrazia del sapere, rischiamo di creare una scienza influencer, seduttiva ma disinnescata.
C’è poi un nodo culturale: chi comunica la scienza? Non basta un account Twitter. Servono competenze, sensibilità, tempo. Delegare tutto questo ai ricercatori, senza supporto o formazione, significa scaricare su di loro un’altra responsabilità, un’altra ansia da prestazione, un altro algoritmo da nutrire.
Eppure qualcosa si muove. Alcuni progetti finanziati da Horizon Europe hanno iniziato a collaborare tra loro, a raccontare le proprie attività con linguaggi plurali, costruendo relazioni più umane, più lente. Non è una rivoluzione, ma un segnale.
Forse, più che insegnare alla scienza a twittare, dovremmo insegnare ai social a pensare. Ma questo, per ora, non è nei piani della Commissione.