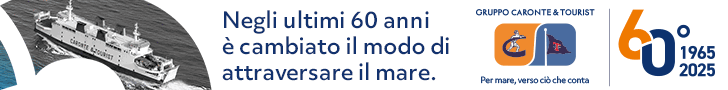L’algoritmo e il deserto. Papa Francesco contro l’illusione dei social

di Giuseppe Miccoli
Nel tempo della connessione perenne, della sovrabbondanza di stimoli, dell’onnipresenza dei like e delle stories, arriva — puntuale e fuori tempo — la voce dissonante di Papa Francesco. Il 26 agosto 2023, in un intervento che ha il tono sommesso delle cose serie, il pontefice ha denunciato i rischi strutturali dei social media. Non come moralista d’altri tempi, ma come osservatore lucido di un’epoca in cui la realtà si dissolve dietro uno schermo.
Per Francesco, le piattaforme digitali stanno trasformando la comunicazione in un’esperienza ridotta, algoritmica, performativa. Le relazioni umane — dice — rischiano di “essere ridotte a semplici algoritmi”, in una logica in cui ciò che non è misurabile diventa irrilevante. L’empatia, l’ambiguità, il silenzio: tutto ciò che rende autentico un incontro, è sacrificato all’altare dell’efficienza computazionale. Una disumanizzazione 2.0.
Ma la vera accusa non è (solo) all’algoritmo. È alla logica sociale che lo nutre. I social media, per Francesco, non sono più uno spazio neutro di espressione individuale, ma una macchina che amplifica disinformazione, propaganda, partigianeria, odio. E lo fa attraverso un’illusione: quella della “comunità digitale”. Giovani e adulti, intere generazioni, cercano appartenenza in un luogo che restituisce invece solitudine confezionata in notifiche.
In un’epoca in cui anche la fede viene brandizzata, il Papa richiama la Chiesa — e l’umanità — a una “cultura dell’incontro autentico”. Parole semplici, ma radicali. Incontro: cioè corpo, voce, ascolto, tempo condiviso. Contro la frenesia del feed, contro la bulimia dell’aggiornamento costante, Francesco suggerisce un gesto sovversivo: fermarsi. Guardare l’altro negli occhi. Accettare la lentezza. Dire “noi” senza bisogno di un hashtag.
Questo discorso non è solo per credenti. È per chiunque si interroghi su come restare umani in un mondo automatizzato. È per chi insegna, per chi comunica, per chi lotta contro la mercificazione delle emozioni. È per chi ancora crede che il linguaggio non sia solo trasmissione di contenuti, ma costruzione di senso.
La lezione di Francesco non è nostalgia né demonizzazione del progresso. È una chiamata a riappropriarsi della parola. A difendere lo spazio del dubbio, dell’ambiguità, dell’inutile. In un’epoca di comunicazione compulsiva, il vero scandalo è il silenzio.
E allora forse — mentre scorriamo l’ennesimo reel — possiamo chiederci: stiamo comunicando o stiamo semplicemente esistendo dentro un flusso che ci ha già cancellati?