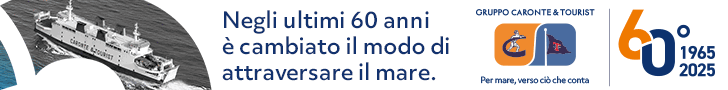Like, corpo, algoritmo

Sessualità e identità nella vetrina digitale: educare o sedurre?
di Giuseppe Miccoli
Nel 2003 un’adolescente siciliana firmava con uno pseudonimo un libro destinato a scuotere la quiete ipocrita della provincia italiana. 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire raccontava il corpo, il sesso, la solitudine, il desiderio, con una sincerità quasi brutale. Per settimane fu il simbolo di una generazione irrequieta e desiderante, per mesi riempì talk show, dibattiti televisivi, pagine culturali. Oggi, un libro così forse finirebbe direttamente nel feed di TikTok, raccontato in tre clip da 30 secondi tra un tutorial sul contouring e una reaction a una transizione gender.
Nel frattempo, la scena è cambiata. O meglio, è diventata scena permanente. Ogni corpo, ogni volto, ogni storia – reale o meno – è potenziale spettacolo. E il sesso? Più che atto, è immagine. Più che esperienza, è esposizione. E si consuma – senza consumarsi – nei riflessi multipli del display.
Non si tratta di nostalgia per tempi più pudici (che non lo erano affatto), ma di interrogarsi sul ruolo educativo dei social media in materia di identità, genere e sessualità. Perché se è vero che piattaforme come Instagram o TikTok hanno dato voce e visibilità a narrazioni prima marginali o invisibili – dai percorsi di transizione alla libertà corporea femminile – è altrettanto vero che oggi bambini e preadolescenti imparano il sesso non più dai coetanei o dalla scuola, ma dall’algoritmo.
L’adolescenza non è più un tempo di formazione, ma una finestra pubblicitaria. Il corpo – in particolare quello femminile – non è soggetto, ma superficie da ottimizzare per lo sguardo altrui. E tutto questo avviene sotto la costante approvazione-disapprovazione del like, del commento, del follow. Sotto lo sguardo giudicante, spasmodico, famelico di una società che ha trasformato la sessualità in capitale sociale.
Le ragazze – sempre più giovani – performano una femminilità preconfezionata, un erotismo pronto uso, che non scandalizza più nessuno, ma che interroga chi ancora si ostina a credere che l’educazione, quella vera, debba passare da relazioni reali e non da reels.
Non è questione di moralismo. È questione di responsabilità.
Se la scoperta del desiderio, dell’identità, della carne, passa esclusivamente attraverso le dinamiche del mercato e dell’autopromozione digitale, quale spazio resta per il dubbio? Per la complessità? Per la costruzione autonoma del sé?
Nel silenzio delle istituzioni scolastiche, nel vuoto di una politica culturale incapace di affrontare davvero la questione dell’educazione digitale, chi resta a interrogarsi? Psicologi, educatori, pedagogisti – voci preziose, spesso ignorate – ci ricordano che non basta esprimere, bisogna anche comprendere. Non basta mostrare, bisogna anche mediare. Non basta raccontarsi, bisogna anche imparare ad ascoltarsi.
E mentre il femminismo si frantuma tra empowerment sponsorizzato e algoritmi patriarcali, il corpo femminile continua ad essere il campo di battaglia più esposto, più cliccato, più performato. Ma anche più fragile.
Forse serve meno indignazione e più formazione. Meno nostalgia e più responsabilità. Meno giudizio, e più presenza adulta. Perché il sesso, il genere, l’identità – anche in epoca digitale – restano processi profondamente umani. E non ci sarà algoritmo, per quanto preciso, che potrà mai sostituire il valore di uno sguardo consapevole, di un ascolto vero, di una domanda posta con attenzione.