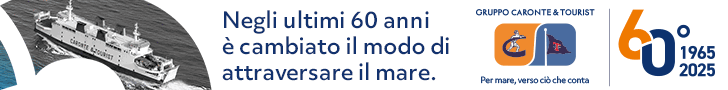di Giuseppe Miccoli
C’è stato un tempo in cui il silenzio era concesso. In cui l’assenza era un diritto, la lontananza una condizione naturale della vita quotidiana. Poi è arrivato WhatsApp — e con lui la frenesia del contatto perpetuo, la compulsione a esserci sempre, la tirannia di quella doppia spunta azzurra che vigila sulle nostre risposte, sui nostri ritardi, sui nostri silenzi.
La domanda che dovremmo farci è semplice e brutale: come sarebbe stata la nostra vita senza WhatsApp? Forse più lenta, forse meno “produttiva” — almeno nella distorta definizione di produttività che domina oggi — ma probabilmente anche più libera. Senza l’assillo della reperibilità, senza l’ansia che si insinua tra le dita ogni volta che lo schermo si illumina. Senza il peso, invisibile ma concreto, del dover essere costantemente presenti nell’altrove digitale.
Oggi la comunicazione non è più solo un ponte: è una catena. Una catena che avvolge amici, colleghi, amori, sconosciuti e familiari in un’unica matassa di notifiche. Non c’è più distanza tra il momento lavorativo e quello personale, tra l’orario d’ufficio e la cena in famiglia. Il lavoro, attraverso WhatsApp e gli altri strumenti di messaggistica istantanea, si è infilato nelle pieghe intime del nostro tempo, erodendo il confine tra vita e occupazione. La reperibilità è diventata un dogma, l’invisibilità un atto di diserzione.
Il lavoro cambia, dunque, nella sua stessa natura. Non è più una funzione scandita da ore e luoghi, ma una tensione continua verso il “pronto intervento”, verso il “rispondi adesso”, verso il “perché visualizzi e non rispondi?”. Si accorcia la distanza tra la domanda e la risposta, ma si allunga la catena dell’alienazione. Non c’è più tempo per pensare, rielaborare, rispondere con consapevolezza: la risposta deve essere immediata, il pensiero già consumato, la presenza già garantita.
Così il grande inganno della tecnologia istantanea si rivela: la promessa era quella di liberarci dai vincoli spazio-temporali, di renderci più autonomi, più agili, più connessi. La realtà è un’altra: siamo diventati dipendenti dalle macchine che dovevano servirci, prigionieri volontari dei nostri dispositivi, schiavi sorridenti delle loro sirene luminose.
Il problema non è solo WhatsApp, naturalmente. È il sistema che si è costruito attorno alla nostra ansia di comunicare, attorno alla nostra paura del silenzio, del vuoto, della disconnessione. È l’idea che il valore di una persona si misuri dalla velocità con cui risponde, dalla quantità di conversazioni che riesce a gestire contemporaneamente, dalla sua costante disponibilità.
Senza WhatsApp, forse, saremmo ancora capaci di perdere tempo. Di non sapere, di non rispondere, di lasciare in sospeso. Saremmo capaci di assaporare il silenzio come spazio di libertà, non come minaccia. Saremmo capaci, persino, di dimenticarci degli altri senza per questo sentirci in colpa.
Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di rimettere in discussione la nostra adesione acritica ai suoi ritmi. Di rivendicare il diritto a non rispondere, a non esserci, a non essere “reperibili” come se fossimo merci su uno scaffale. Di pensare che forse l’umanità non ha bisogno di essere più veloce, ma più lenta. Non più connessa, ma più consapevole.
La libertà, oggi, passa anche dal silenzio. Dal disattivare il baffo blu. Dal riscoprire il valore dell’assenza. E forse, da un piccolo gesto rivoluzionario: spegnere il telefono, uscire di casa e camminare senza meta, senza notifiche, senza ansie. Con il coraggio di essere, finalmente, irrimediabilmente offline.