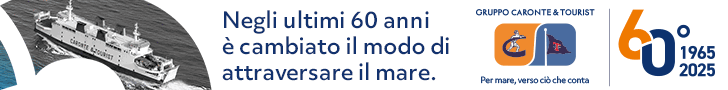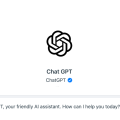Scuola e intelligenza artificiale: il paradosso degli studenti invisibili

di Giuseppe Miccoli
Otto studenti su dieci usano l’intelligenza artificiale generativa. Ma i loro professori non se ne accorgono. È il dato che emerge dal primo studio nazionale sull’impatto dell’IA nelle scuole italiane. Una fotografia amara, che racconta di un sistema educativo in ritardo e di un rapporto tra studenti e insegnanti sempre più segnato da silenzi e incomprensioni.
Gli alunni utilizzano ChatGPT e strumenti simili per fare i compiti, scrivere temi, preparare interrogazioni. Lo fanno in segreto, quasi con il senso di colpa di chi commette un illecito. I docenti, al contrario, vivono nella convinzione che le loro classi non ricorrano a queste scorciatoie. È il segno di una frattura che ricorda altri passaggi storici: quando i giovani scoprivano linguaggi e strumenti che gli adulti non volevano – o non sapevano – decifrare.
Negli anni Settanta e Ottanta le radio libere, il rock, i collettivi studenteschi portarono nuove forme di espressione e conflitto. La scuola, spesso, non seppe intercettare quella spinta, preferendo ignorarla. Oggi la scena si ripete: gli studenti si muovono dentro un ecosistema digitale che li forma più della stessa aula. E gli insegnanti restano ai margini, come spettatori distratti.
La questione non è se l’IA sia buona o cattiva, ma il vuoto pedagogico che circonda il suo utilizzo. Nessuno spiega agli studenti come funzionano gli algoritmi, quali rischi comporta affidarsi a testi preconfezionati, come distinguere la creatività vera dall’automatismo di una macchina. Il pericolo non è tanto copiare un compito, quanto crescere senza più capacità critica.
Eppure il passato dimostra che la scuola, quando ha avuto il coraggio di accogliere le trasformazioni, è riuscita a cambiare la società. La riforma della scuola media unica negli anni Sessanta portò un’intera generazione fuori dall’analfabetismo. Negli anni Novanta, seppur lentamente, i computer entrarono in aula, avviando un primo processo di alfabetizzazione digitale.
Oggi la sfida è ancora più radicale. Non basta distribuire tablet o vietare l’uso dell’IA. Bisogna educare al suo impiego consapevole, trasformare le classi in laboratori di pensiero critico. Significa accettare che le macchine generative ci accompagneranno, ma senza sostituirsi al giudizio umano.
La vera alternativa non è tecnologica ma culturale: più libri e meno intelligenza artificiale. Più tempo in biblioteca e meno tempo su Instagram o TikTok. Più dibattiti in classe, più viaggi d’istruzione, più esperienze concrete che insegnino a leggere il mondo.
E soprattutto: utilizzare di più la propria testa. Scrivere con le proprie parole, anche sbagliando l’ortografia, anche con qualche verbo storto, ma esprimendo i propri pensieri. Perché l’errore, in fondo, è parte dell’apprendimento. L’IA invece cancella la fatica e con essa cancella anche la possibilità di crescere.
Il rischio non è un compito copiato, ma una generazione allenata a delegare il pensiero alle macchine. La scuola dovrebbe invece mostrare che dietro ogni parola c’è un corpo, una storia, un conflitto, e che la creatività nasce dal confronto con la realtà, non dall’automazione.
La lezione viene dal passato: ogni volta che la scuola ha deciso di affrontare i cambiamenti, ha aperto spazi di emancipazione. Ogni volta che li ha ignorati, ha lasciato i ragazzi soli. E la solitudine, per chi studia, è sempre il primo passo verso la rassegnazione.