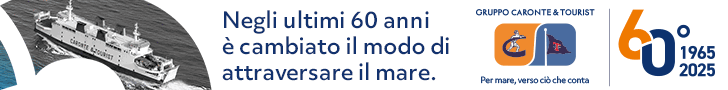Social media, gennaio 2023: l’illusione della novità permanente

di Giuseppe Miccoli
Gennaio 2023 si apre con l’ennesima sfilata di novità nel mondo dei social network, un carosello di aggiornamenti che più che segnare rivoluzioni sembrano reiterare un rito ormai consueto: cambiare tutto per non cambiare nulla. In un panorama saturo, ogni piattaforma rincorre la prossima scintilla capace di catturare l’occhio distratto dell’utente, trasformando la socialità digitale in un esperimento continuo e spesso superficiale.
Instagram inaugura l’anno con Notes, una funzione che ricorda i vecchi status di MSN: brevi messaggi di 60 caratteri visibili soltanto nella casella dei follower o degli amici più stretti. Un tentativo di restituire intimità a uno spazio che ha perso gran parte della sua spontaneità, logorato dall’estetica patinata e dall’algoritmo che premia solo ciò che appare virale. Notes sembra dire: parlate piano, raccontatevi con un pensiero rapido, quasi privato. Ma dietro il velo nostalgico si intravede l’ennesimo tentativo di trattenere gli adolescenti che, altrove, sperimentano forme di comunicazione più dirette e meno sorvegliate.
Sempre Instagram, insieme a Facebook, testa le Candid Stories, copia quasi perfetta di BeReal: scatti spontanei, non filtrati, che si attivano con una notifica casuale. Un format che vorrebbe sottrarre tempo al rivale francese, riportando autenticità dove ormai regnano filtri e strategie da micro-influencer. Ma l’autenticità, quando viene istituzionalizzata dentro un colosso miliardario, rischia di diventare una nuova forma di marketing: essere “reali” per generare più engagement.
Nel frattempo, i profili professionali di Instagram ricevono un nuovo strumento di trasparenza (o di controllo): la possibilità di sapere se un contenuto può essere raccomandato a utenti non follower. Una sorta di pagella algoritmica, con tanto di diritto di appello. Qui la novità è meno ludica e più strutturale: un passo che trasforma la creatività in un continuo negoziato con l’intelligenza artificiale che decide chi merita visibilità e chi no.
Twitter, travolto dalle manovre di Elon Musk, ripropone Twitter Blue, l’abbonamento che promette privilegi agli utenti paganti. Una svolta che sancisce il definitivo passaggio dalla promessa di “piazza pubblica globale” al modello “pay to be heard”: chi paga, parla più forte; chi non può, resta ai margini del flusso. È la contraddizione più lampante di questo inizio anno: la promessa di una democrazia comunicativa ridotta a servizio premium.
E poi c’è TikTok, che per alcuni utenti sperimenta una modalità orizzontale a schermo intero, a metà strada tra YouTube e la televisione. Il gesto verticale che ha reso iconica la piattaforma lascia spazio al respiro largo dell’orizzonte: non più micro-pillole da scorrere compulsivamente, ma un tentativo di conquistare la narrazione lunga, il campo dei video più strutturati. Una mossa che conferma l’ambizione di TikTok: non essere più soltanto il social della Gen Z, ma il nuovo ecosistema di intrattenimento universale.
Dietro questo mosaico di innovazioni si nasconde una verità che gli utenti avvertono in modo sempre più nitido: le piattaforme social non innovano per noi, ma per sé stesse. Ogni aggiornamento non risponde a un reale bisogno collettivo, bensì alla competizione senza tregua per il tempo, l’attenzione e i dati. Notes, Candid Stories, Twitter Blue o lo schermo orizzontale non sono che strumenti in una guerra silenziosa: quella per il monopolio della nostra presenza digitale.
Il paradosso è che in questo gennaio 2023 i social sembrano più che mai voler imitare se stessi: Instagram rincorre BeReal, TikTok sfida YouTube, Twitter si inventa un club esclusivo per paganti. L’unica costante è la ricerca ossessiva di un coinvolgimento che appare sempre più artificiale, una recita di spontaneità programmata.
Forse il vero cambiamento, oggi, non arriva dalle piattaforme, ma dagli utenti che progressivamente le attraversano con disincanto, oscillando tra il desiderio di esserci e la consapevolezza di quanto la loro voce venga compressa in formati prefabbricati. La domanda che resta sospesa è: riusciremo a ritrovare una comunicazione che non sia solo l’eco di un algoritmo?