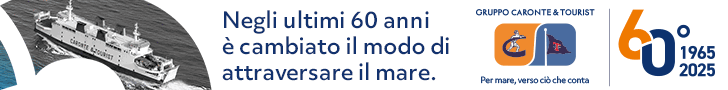Transizioni digitali

Social media, identità di genere e nuove generazioni: educare, non demonizzare
di Giuseppe Miccoli
C’era un tempo in cui parlare di identità di genere, transizione o orientamento sessuale era un gesto confinato a testi specialistici o a rari incontri protetti. Oggi, bastano pochi minuti su TikTok o Instagram per incontrare volti giovanissimi che raccontano pubblicamente il proprio percorso di transizione: il primo giorno di terapia ormonale, il coming out in famiglia, la scelta di un nuovo nome.
I social media hanno aperto uno spazio di visibilità inedito per molte soggettività storicamente marginalizzate. Hanno dato voce, comunità, linguaggi. Ma hanno anche spalancato questo universo narrativo a un pubblico molto più ampio e, spesso, molto più giovane. Pre-adolescenti e bambini oggi accedono con facilità a contenuti che trattano temi complessi legati al corpo, all’identità, alla sessualità.
La domanda è lecita: questo tipo di esposizione precoce è educativa o disorientante?
E soprattutto: chi può – e deve – rispondere a questa domanda?
Noi non intendiamo offrire risposte facili. Né vogliamo unirci a chi invoca censura o repressione. Vogliamo piuttosto aprire un dibattito: serio, laico, informato. Un dibattito che coinvolga figure competenti – psicologi, educatori, pedagogisti – capaci di analizzare con rigore e sensibilità il ruolo formativo (o deformativo) che i social media possono avere nella costruzione dell’identità.
La psicologa Lorenza Paponetti, in un’analisi pubblicata su State of Mind, sottolinea come “gli adolescenti LGBTQIA+ trascorrono molto più tempo online e godano di benefici significativi nell’utilizzo dei social media”. La rete, dunque, come spazio di riconoscimento, di condivisione, di legittimazione. Un luogo dove finalmente sentirsi meno soli.
Ma non mancano voci critiche. Lo psicologo sociale Jonathan Haidt, nel suo recente The Anxious Generation, osserva che “il passaggio da un’infanzia basata sul gioco a un ambiente dominato dalla tecnologia ha aumentato ansia, depressione e fragilità psicologiche negli adolescenti”.
In questo scenario complesso, ciò che spesso manca è una cornice educativa, una mediazione adulta, un accompagnamento capace di offrire chiavi di lettura. “Non possiamo chiedere a un undicenne di orientarsi da solo tra concetti come gender fluid, identità queer o disforia” – spiega Andrea R., educatore scolastico – “Servono adulti preparati, capaci di ascoltare e spiegare senza ideologie né tabù”.
Il problema, quindi, non sono i contenuti, ma la solitudine con cui vengono recepiti. Non è questione di vietare, ma di educare all’informazione, al linguaggio, al dubbio. Serve più scuola, più formazione, più ascolto. E soprattutto serve la volontà di costruire una pedagogia del presente, in grado di accogliere il cambiamento senza cedere al panico morale.
Parlare di genere non è un rischio. È una necessità. E in un tempo in cui anche le transizioni più intime passano per uno schermo, la vera responsabilità adulta non è quella di spegnere il telefono. Ma di sedersi accanto ai più giovani, e guardare insieme.