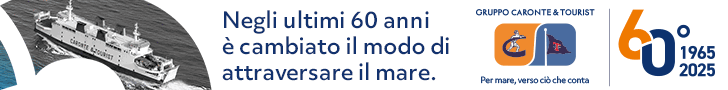Tutte le password della nostra vita

di Giuseppe Miccoli
Vent’anni fa, la mia giornata scolastica aveva il ritmo rassicurante di poche cose: la Smemoranda, una penna senza tappo, i libri premurosamente disposti nello zaino e il caricabatterie del mio Nokia 3330 — quell’oggetto piccolo e ostinato che, nonostante gli anni, continua a funzionare come un proverbio. Per aprire quel mondo bastava un PIN di quattro cifre. Quattro numeri, una soglia minima, quasi un rituale semplice: premi, entra. Dentro c’erano elenchi coi soprannomi, qualche SMS che valeva più di un diario, frasi scambiate con la leggerezza del tempo, e una memoria che custodiva desideri e imbarazzi alla stessa altezza di un sonetto di Cielo d’Alcamo.
Oggi questo gesto, che allora era una sorta di gentilezza meccanica, è diventato una lunga fila di passaggi. Non solo il PIN: l’ADSL, una password per la posta Hotmail, gli accessi alla chat di MSN — eravamo all’inizio di una casa più vasta, fatta di fili e codici. Ma ciò che sembra un progresso, se lo guardiamo bene, è anche un sovraccarico. Non siamo più soltanto gironi di nome e cognome, siamo interi profili distribuiti in server lontani. Email, portali, account di ogni natura, banche, app per la spesa, per la salute, per il lavoro, per il tempo libero. Con lo SPID, la Pubblica Amministrazione ha provato a mettere ordine: una chiave unica per molte porte. Ma la serratura resta digitale, e le chiavi si moltiplicano.
Le password non sono neutre: sono piccole tessere d’identità, minuscole mappe di ciò che siamo. Le scriviamo su foglietti nascosti, le recuperiamo con il sollievo di chi ritrova un oggetto perduto. Le automatizziamo in gestori che promettono sicurezza e pace, ma che ci trasferiscono l’ansia in una cassaforte elettronica. Ogni nuova registrazione ci chiede «crea una password sicura»: un imperativo che spesso si traduce in combinazioni impenetrabili per la memoria eppure fragili per la nostra vita affettiva. Così la privacy si disfa in tecnicismi e la fiducia si acquista a colpi di aggiornamenti.
C’è una dimensione politica in tutto questo. Non è solo questione di comodità personale: è il modo in cui il capitalismo digitale ridefinisce l’accesso ai diritti. Chi non ha credenziali aggiornate rischia di restare fuori da servizi essenziali. Chi perde l’accesso a un account perde una parte della propria esistenza amministrativa, lavorativa, relazionale. Le password diventano così nuovi passaporti sociali: non valgono solo per aprire una mail, ma per esistere nella pubblica sfera. E mentre lo Stato si arrotola su procedure di autenticazione, le grandi piattaforme privatizzano l’identità con i loro sistemi proprietari, imponendo standard, cancellando account, decidendo invisibilmente chi resta e chi esce.
Allo stesso tempo, la proliferazione di codici ci impone un mestiere inatteso: la manutenzione della memoria. Impariamo regole mnemoniche, inventiamo ancore, usiamo frasi che sembrano poemetti per ricordare una sequenza di numeri e simboli. Impariamo a non fidarci delle nostre memorie, e a delegare al dispositivo — così come ci affidiamo al caricabatterie per dare nuova vita al telefono antico. Ma delegare significa anche dipendere: quando il gestore fallisce, quando il server si corrompe, quando la politica di una piattaforma cambia, allora si spezza quella dipendenza. E sono i più fragili a pagarne il prezzo.
Il tema dell’educazione digitale diventa dunque cruciale. Non basta insegnare a creare password complesse: bisogna tornare a spiegare la relazione tra la nostra vita e la sua rappresentazione digitale, tra il limite della memoria e l’abuso della memorizzazione esterna. Bisogna reclamare una sovranità che non sia solo tecnica, ma civica. Serve che le istituzioni pensino a soluzioni che non obblighino il cittadino a diventare un ingegnere della propria identità, soluzioni che garantiscano alternative umane alla logica della complessità.
E poi c’è una parola che è sempre dimenticata quando parliamo di codici: cura. Curare gli account, aggiornare le password, proteggere le persone più vulnerabili nell’uso del digitale — è un’azione quotidiana che richiede tempo e responsabilità collettiva. È un lavoro di comunità che può essere svolto da scuole, aziende e amministrazioni insieme: alfabetizzazione, strumenti chiari e accessibili, supporto per chi è escluso. Perché esistere online non è un privilegio, è una condizione pratica della vita contemporanea.
La nostalgia per il caricabatterie del Nokia non è solo un vezzo vintage: è il ricordo di una semplicità che non significa arretratezza, ma limiti che proteggevano. Oggi siamo troppo spesso schiavi di una complessità che non abbiamo scelto. Tutte le password della nostra vita, così numerose e dispettose, ci chiedono una risposta collettiva: trasformare la sicurezza in diritti, la tecnica in solidarietà, la memoria artificiale in memoria condivisa. Non basta ricordare: bisogna decidere come vogliamo essere ricordati — e da chi.